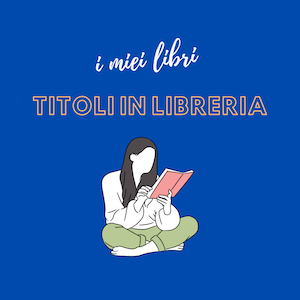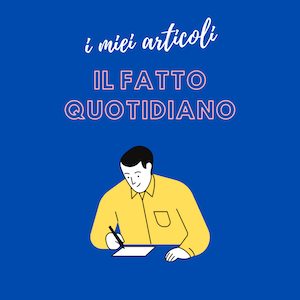Altri blog
 |
 |
 |
 |
 |
RESTIAMO IN CONTATTO!
PER CONOSCERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI VISITA LA MIA PAGINA FACEBOOK
La leggenda del mostro del Lago Biviere: A Biddina
Tra le tante creature straordinarie che popolano il Lago Biviere di Gela, si narra che le acque del Lago fossero frequentate da una presenza inquietante: un gigantesco serpente le cui sembianze ricorderebbero un rettile estinto del Paleocene, capace di ipnotizzare chiunque passava di lí per poi divorarlo.
La leggenda narra che alcuni cacciatori, durante una battuta di caccia, appostati tra i canneti del lago Biviere, in attesa che le folaghe si levassero in volo, furono attratti dal síbilo e dall’apparizione improvvisa di un grosso rettile tutto ricoperto di scaglie dalla testa alla coda.
Veniva dalla terraferma ed era diretta verso il lago.
Era la “biddina”, una bestia leggendaria, un mostruoso rettile dalla circonferenza di un “vuttazzeddu di una sarma di vino” e dalle dimensioni titaniche.
Lungo più di 10 metri, coperto di squame corazzate, questo serpente dagli occhi rossi paralizzò i cacciatori. Alcuni di loro riuscirono a scappare e raggiunto il paese urlarono “a biddina scappau”.
L'articolo La leggenda del mostro del Lago Biviere: A Biddina proviene da Gela Le radici del Futuro.
Acropoli di Gela
Situata in Prossimità del Museo Archeologico Regionale, l’ Acropoli di Gela è uno dei siti archeologici di maggiore rilievo
in Sicilia. Luogo della fondazione dell’ antica Gela, l’ area risulta essere uno straordinario esempio di stratificazione
storica.
La prima fase registrata dagli scavi effettuati tra gli anni ’50 e ’60 del ‘900 ,provano che l’ area, prima dell’ arrivo dei coloni
rodio-cretesi, era già occupata in epoca preistorica da insediamenti indigeni databili tra il IV ed il II millennio a.C..
Dopo una fase di abbandono, il sito fu nuovamente occupato intorno all’ VIII secolo a. C. da un piccolo insediamento
precedente alla fondazione di Gela , una proto-colonia alla quale era stato dato il nome di Lindioi, come riportato dagli
storici Tucilide ed Erodoto. Lindioi fu dunque un primo avamposto-emporio che aprì la strada alla fo0ndazione di Gela
da parte dei rodiesi guidati da Antifemo e dei cretesi guidati da Entimo.
Nella prima metà del VII secolo a. C. nell’area furono costruiti alcuni edifici come ad esempio un sacello dedicato ad
Athena Lindia, la dea protettrice della città, i cui resti furono poi inglobati nelle fondazioni di un secondo tempio
costruito nel corso del VI secolo a.C. e dedicato ancora ad Athena.
È nel V secolo a.C. che l’ acropoli subisce le maggiori trasformazioni. Sotto i Dinomenidi, tiranni della città, si da inizio ad
un importante progetto di monumentalizzazione attraverso la costruzione di imponenti edifici. Nel 480 a.C. a seguito
della vittoria dei greci sui cartaginesi nella grande Battaglia di Himera, il tiranno di Gela Ierone decide di edificare un
nuovo tempio dedicato ad Athena, di cui oggi ci rimane una sola colonna.
L’ edificio sacro, con peristasi di 6 x 12 colonne, fu ornato da elementi marmorei importati dalle Cicladi, decorati da
motivi policromi. Anche gli altri edifici della zona furono sfarzosamente arricchiti da elementi architettonici, quali
acroteri equestri ed antefisse fittili.
L’ acropoli, come dimostrano alcuni strati di macerie, fu distrutta nel 405 a.C. a seguito del saccheggio della città da parte
dei cartaginesi guidati da Himilko. Attraverso il riutilizzo dei materiali e delle vestigia degli antichi templi, venne
impiantata tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C. una stoà (mercato), ancora oggi visibile nelle strutture ben
conservate poste sul lato nord.
A seguito della rifondazione di Gela (339 a.C.) da parte di Timoleonte sul lato ovest della collina, l’ area dell’ acropoli
venne definitivamente abbandonata. Dell’ antico sito primigenio non rimanevano che alcune colonne, di cui ci rimangono
tracce storiche nei racconti di Edrisi (XII sec. d.C.) e Guido delle Colonne (XIII sec. d.C.).
L'articolo Acropoli di Gela proviene da Gela Le radici del Futuro.
Nel 2025 Cuore Basilicata ha aiutato a far conoscere meglio la Val d’Agri
Quasi mezzo milione di visualizzazioni di CuoreBasilicatas.it
Anche nel 2025 e ancor più rispetto agli anni precedenti Cuore Basilicata ha contribuito a diffondere l’immagine positiva della Val d’Agri tra un vasto publico in Italia e non solo. Lo dicono alcuni numeri:
Utenti siti web Cuore Basilicata: 152.714
Pagine viste: 494.111
Follower Facebook: 5.961
Follower Instagram: 3.993
Visualizzazioni Newsletter: 79.911
(dati anno 2025 aggiornati al 22 dicembre)
A questi numeri va aggiunto il successo mediatico delle terza stagione della pluripremiata web serie Cuori Lucani che nell’arco del primo mese dal suo lancio nel web e nei social ha già superato le 150.000 visualizzazioni.
Risultati importanti ottenuti grazie alle qualità naturali, culturali, storiche, artistiche del territorio e all’impegno delle persone che lo vivono.
Il sistema web del progetto CuoreBasilicata si compone di siti collegati, rinnovati e adeguati secondo le più recenti evoluzioni tecnologiche e tendenze.
- cuorebasilicata.it rappresenta l’hub del sistema, contiene tutte le informazioni principali sulle attrattive dell’area e gli aggiornamenti sulle iniziative culturali, artistiche… attraverso articoli e news.
- infopointcuorebasilicata.it, un Infopoint virtuale che, oltre a contenere la descrizione di ciascuno degli 11 Comuni, consente ai visitatori di ricevere informazioni tramite messaggistica.
- visitcuorebasilicata.it, l’infografica che consente ai viaggiatori di organizzare la propria visita in autonomia, scegliendo le tappe del percorso giudicate di maggiore interesse.
Ai siti si affiancano le pagine di Cuore Basilicata sui social (Facebook, Instagram e, per la parte video, YouTube con anche un canale ad hoc dedicato a Cuori Lucani), che aggiornano costantemente i follower sulle iniziative che si tengono nei Comuni dell’area.
A completare il sistema informativo online di Cuore Basilicata contribuisce poi una newsletter periodica (quella che state leggendo ora) che promuove il territorio, rivolta ai cittadini e ai potenziali visitatori.
Grazie di cuore a tutte e tutti quelli che hanno collaborato, alle Amministrazioni che patrocinano Cuore Basilicata, a Eni che ha sostenuto il progetto.
Bruno Patierno, coordinatore di Cuore Basilicata.
Il 2026 del Parco Appennino Lucano: “Ambizione Ambientale”.
A colloquio con Antonio Tisci, presidente del Parco.
Antonio Tisci, presidente del Parco Appennino Lucano, ha attraversato il 2025 prima come commissario del Parco e poi come presidente. Partiamo da questo: è cambiato qualcosa nel passaggio da commissario a presidente?
Diciamo che dal punto di vista dei poteri e delle funzioni non ci sono cambiamenti sostanziali, la situazione cambierà quando la Comunità del Parco e i Ministeri competenti nomineranno il direttivo del Parco, che sarà un organo collegiale che mi affiancherà. Mi auguro che avvenga quanto prima così da poter condividere con il direttivo le scelte strategiche nella gestione dell’Ente.
Il 2025 cosa ha rappresentato per il Parco?
Nel 2025, in continuità con il 2024 abbiamo operato su due linee principali:
- il consolidamento della struttura amministrativa dell’Ente. Senza fare nuove assunzioni e grazie all’attività egregia del direttore del Parco e dei funzionari abbiamo avviato una serie di pratiche anche sbloccando fondi che erano fermi da tempo e che ci hanno consentito di avviare nuove iniziative;
- l’altra linea di attività che abbiamo portato avanti riguarda la tutela del territorio tramite la sua valorizzazione sulla base dell’idea forza secondo cui la difesa del territorio può e deve essere svolta con il contributo e il coinvolgimento dei cittadini. I cittadini apprezzeranno la tutela ambientale comprendendo i vantaggi che da questa derivano non solo per l’ambiente ma anche per la comunità. Il rispetto della biodiversità è nell’interesse dei cittadini.
Ecco, parliamo di tutele ambientale. È possibile fare qualche esempio di attività realizzate nell’anno?
A Spinoso abbiamo realizzato un centro studi sulla biodiversità che stiamo convenzionando con il mondo universitario. Grazie a questo dei ricercatori universitari verranno ad effettuare degli studi importanti sulle peculiarità ambientali del Parco.
Assieme all’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stiamo controllando il DNA ambientale della matrice acqua all’interno del Parco.
Dopo il successo della prima edizione, abbiamo realizzato la seconda edizione di NAIADI su lago Sirino, la manifestazione ideata per promuovere un dialogo concreto e propositivo sul futuro delle aree protette,
Stiamo lavorando poi alla promozione del territorio. Ad esempio abbiamo fatto realizzare un video che racconta i passaggi generazionali in atto nell’ambito della pratica della transumanza.
E segnalo anche una serie di sentieri che stiamo organizzando come ad esempio il “Cammino dei Cinti” che ripercorre i sentieri della transumanza e delle chiese extramurarie collegate.
Stiamo poi lavorando con Slow Food a favore dei prodotti tipici del territorio. La nostra ambizione in prospettiva è realizzare un marchio di qualità dei prodotti del Parco che dia valore aggiunto ai prodotti di eccellenza.
Tra le attività ce ne sono anche che riguardano la fauna?
Voglio citare una “chicca” che segnala il nostro modus di operare. Avevamo delle risorse assegnateci dal Ministero per la tutela dell’ululone, un piccolo anfibio in via di estinzione. Questo anfibio ama vivere nei fontanili per uso rurale. Abbiamo preso spunto da questo per avviare la ristrutturazione di oltre 20 fontanili all’interno del Parco ed abbiamo sottoscritto un protocollo con l’associazione regionale allevatori grazie al quale gli associati potranno beneficiare dei fontanili per far abbeverare i loro animali e al contempo si impegnano ad assicurare la manutenzione dei fontanili recuperati. Avremo così dei pastori custodi della biodiversità.
In termini di fauna un tema molto sentito dalla comunità è poi il contenimento numerico dei cinghiali presenti sul territorio. Abbiamo e stiamo operando in questa direzione e un risultato concreto è stato anche il far uscire i cinque comuni del Parco confinanti con la Campania dall’area di restrizione.
Nell’insieme, qual è l’idea guida che il Parco deve perseguire secondo lei?
L’idea è costruire un Parco che sia vicino ai cittadini e al contempo strumento di sviluppo del territorio: lo sviluppo attraverso la tutela. Ho coniato un claim per il Parco: “Ambizione Ambientale”. Ambizione Ambientale evoca la circolarità tra esseri umani e ambiente e la necessità di mantenere equilibrio e armonia tra loro.
Parliamo ora del 2026. Quali sono le previsioni e i programmi per il Parco?
Sicuramente proseguiremo sulle linee su cui ci siamo mossi nel 2025.
A questo vorrei aggiungere che il nostro impegno sarà sempre più orientato al pieno coinvolgimento della comunità del Parco: amministrazioni cittadine, associazioni, imprese, scuole, una strada indispensabile per dare forza e senso a tutti i nostri sforzi.
In prospettiva poi vedo forme anche di “allargamento” del coinvolgimento anche di territori limitrofi e di quanti li frequentano. A poca distanza dai confini del Parco ci sono importanti località sul mare che attraggono un notevole flusso turistico. Ebbene, far conoscere ai frequentatori di queste località le opportunità che il Parco offre a breve distanza da loro potrebbe orientare molti visitatori verso il nostro territorio.
Più in generale uno degli obiettivi chiave per noi nel 2026 sarà comunque dotarci di strumenti efficaci per la comunicazione del Parco, per far conoscere a livello nazionale e internazionale le opportunità che il Parco offre a chi lo visita. Perché bisogna sempre ricordare che la funzione istituzionale del Parco non si limita solo alla tutela ambientale ma riguarda anche lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato e del turismo.
La leggenda del Castelluccio
La Leggenda del Castelluccio di Gela parla di una bellissima castellana dalla lunga chioma nera che attirava tutti i passanti e i contadini con i suoi canti melodiosi.
Si narra che la bella castellana fosse di corporatura esile, che indossavsse un meraviglioso manto blu e argento, truccata con uno strano rossetto verde. Era una figura dotata di fascino misterioso perché tanto bella quanto crudele, severa e intransigente con i servitori, ambigua, sfuggente.
Durante le sue giornate si occupava della servitù e si prendeva cura dei cavalli.
Tanti uomini erano attratti dalla sua bellezza e dalla sua voce, ma chiunque tentava di avvicinarsi poi scompariva nel nulla.
Chi doveva discutere di affari con lei, inviava i messaggi con i piccioni. Ma anche quelli non facevano più ritorno.
Alcuni raccontano di aver visto di notte un cavaliere con l’armatura aggirarsi intorno alla fortezza, per poi scomparire nell’oscurità.
Questi strani eventi mettevano certamente paura ai numerosi viandanti che, spesso, evitavano di avvicinarsi troppo al castello.
Si racconta anche che fra quelle mura secolari del castello vi fossero dei fantasmi e ombre.
Si dice inoltre che ci fosse nascosto un tesoro ovvero “a travatura” ma finora nessuno è mai riuscito a trovarne traccia.
Non si sa se la Castellana sia veramente esistita in questo castello ma ciò che è vero è che all’interno del castello ci sono dei tunnel sotterranei che lo collegano fin dentro la città di Gela.
L'articolo La leggenda del Castelluccio proviene da Gela Le radici del Futuro.
I rami ‘che ficu
I “rami ‘che ficu” sono, a Gela, i più gustosi e tradizionali dolci di Natale.
Ingredienti necessari e peculiari sono i fichi essiccati durante l’estate.
Il ripieno di questi dolci noti e amati si ottiene con un impasto, appunto, di fichi secchi e vino cotto, anch’esso preparato durante il periodo della vendemmia.
Solitamente i “rami” sono ricoperti dalla “ghiacciata”, un composto emulsionato di zucchero a velo e albume.
Questi dolcetti, preparati quasi esclusivamente durante le festività natalizie, richiamano fortemente le antiche tradizioni.
Ingredienti:
-½ chilo di farina
-15 gr di lievito
-4 tuorli
-150 gr di strutto o burro
-250 gr di zucchero
-scorza di limone
-1 bustina di vanillina
Per il ripieno:
-200g fichi secchi
-150g mandorle
-buccia d’arancia
– 2 cucchiai di vino cotto o marsala
-un pizzico di cannella
Per la glassa:
-2 albumi
-100g di zucchero a velo
-succo di limone q.b.
-codette colorate per la decorazione
Preparazione:
Procedete sbollentando i fichi secchi, in acqua calda per un paio di minuti.
Tritare finemente i fichi secchi appena sbollentati con una lama ben affilata, se volete, potete anche usare un passaverdure.
In una pentola, versare i fichi secchi tritati, aggiungendo la scorza di un’arancia.
Unire al composto del vino cotto o del marsala e far cuocere a fiamma molto bassa per alcuni minuti.
Nel frattempo tritare le mandorle, possibilmente tostate, e aggiungerle al composto assieme, se volete, a una spolverata di cannella.
Mescolare fino a quando il composto sarà ben amalgamato, e poi, lasciatelo riposare per qualche ora.
Procediamo a questo punto a preparare la pasta frolla.
In una ciotola aggiungete alla farina la vanillina e il lievito per dolci. Incorporate lo strutto o il burro, e lavorate velocemente il composto. Aggiungete un pizzico di sale, la scorza di limone grattugiata e i tuorli.
Lavorate l’impasto fino a ottenere un composto omogeneo e liscio.
Avvolgere la frolla con della pellicola da cucina e lasciarla riposare in frigo per un’ora o anche più.
Trascorso questo tempo, procedete stendendo la frolla con l’ausilio di un mattarello, dandole una forma rettangolare.
Farcite adesso la frolla con il ripieno di fichi secchi.
Richiudete la frolla in modo da formare una specie di salsicciotto.
A questo punto, con un coltello, tagliate la frolla in modo da formare dei tronchetti di pasta, ricordandovi di fare, ai lati, le incisioni classiche dei “rami che ficu”
Infornare in forno preriscaldato a 200° sino a quando non si saranno dorati.
A questo punto, tirateli fuori dal forno e lasciateli raffreddare.
Nel frattempo che i “rami che ficu” si raffreddino, prepariamo la “ghiacciata”, ovvero glassa di zucchero.
Lavorate, mediante le fruste l’albume fino a quando vedrete che comincia a diventare bianco, stando attenti a non montarlo a neve.
Aggiungete, molto lentamente, lo zucchero a velo e qualche goccia di limone, mescolando con una spatola, sino a quando non otterrete una glassa bianca.
A questo punto, tramite un pennello, spennellate i “rami” con la glassa.
Aggiungete se volete delle decorazioni, io ho usato delle codette colorate.
Rimettete i “rami” nel forno caldo ma spento, per far si che la glassa si solidifichi.
I vostri “rami che ficu” sono pronti per deliziare il palato di grandi e piccini durante queste feste.
Buon appetito e buone feste!
L'articolo I rami ‘che ficu proviene da Gela Le radici del Futuro.
Tra sogni, scelte e radici: Cuori Lucani, la terza stagione
La web serie Cuori Lucani si presenta come una produzione sincera del territorio della Val d’Agri, capace di coniugare racconto personale, ambiente e identità lucana con uno sguardo capace di parlare anche oltre i confini.
Questa web serie, diretta da Iacopo Patierno, si compone di brevi episodi ciascuno dedicato ad un protagonista che vive nei territori della Val d’Agri.
Le prime 2 stagioni
Nella prima stagione i 7 episodi hanno raccontato la passione per il lavoro e per la propria terra attraverso i volti dei protagonisti, esplorando storie individuali che mettono al centro il rapporto con la terra, il lavoro e l’identità del territorio lucano. I 5 episodi della seconda stagione hanno avuto come filo conduttore la passione di aziende familiari che passano a nuove generazioni tra innovazioni e tradizioni che convivono, allargando lo sguardo non solo su chi ha scelto il “fare” sul territorio ma anche su chi eredita e rilancia, su come generazioni diverse mantengono vivo un legame con la propria terra e lo rinnovano.
La terza stagione
La terza stagione, composta da 5 episodi, ci porta a scoprire, attraverso sport come l’arrampicata, l’equitazione, la pesca sportiva, la mountain bike e il trekking, storie reali e genuine di passione, lontane dal glamour televisivo, che fanno percepire un filo comune che le unisce che è quello della volontà di restare, di far conoscere il proprio territorio, di far crescere qualcosa lì dove il resto del mondo spesso guarda altrove.
Anche questa terza stagione della web serie fa un grande uso del paesaggio lucano che diventa non semplice sfondo, ma parte integrante della narrazione, dello stile visivo e dell’identità dei protagonisti, e questo conferisce autenticità e fascino. Il formato breve e la concentrazione su un solo protagonista per ciascun episodio donano immediatezza; il tono “leggero” e quasi documentaristico, ne contraddistinguono chiarezza, genuinità e semplicità.
Sogni, scelte e radici
Cuori Lucani è una scoperta preziosa per chi ama le narrazioni autentiche, i luoghi meno conosciuti, senza effetti speciali o colpi di scena da blockbuster, senza spettacolarizzare sa emozionare con la quotidianità, con la bellezza discreta della terra lucana e con storie che, se pur locali, parlano di sogni, di scelte e di radici.
Ogni episodio è un piccolo ritratto, un battito di quel grande cuore collettivo che è la Val d’Agri, non ci sono attori ma persone vere, non ci sono scenografie ma paesaggi che respirano insieme ai protagonisti. Il risultato è un racconto che profuma di autenticità, di quella semplicità che troppo spesso si perde nella corsa del mondo. In ognuna di queste storie c’è qualcosa di universale, la passione per la montagna e le sue rocce, la sicurezza di saper montare a cavallo, la pazienza di chi pesca ai margini di un fiume, l’adrenalina di una discesa in mountain bike, la sensazione di benessere che ti regala una passeggiata nei boschi, l’amore incondizionato per la propria terra, il coraggio di restare, la voglia di costruire futuro dove gli altri vedono solo passato.
Cuori Lucani, una dichiarazione d’amore
Forse Cuori Lucani non è una serie nel senso tradizionale del termine, è più una dichiarazione d’amore alla terra, alle radici, ai sogni che crescono piano ma resistono, è la prova che anche con poco, un’idea e tanta verità, si può far fiorire un racconto: le montagne diventano spalle, i fiumi parole, il vento una voce che ti dice che restare non è immobilità ma scelta. Non serve conoscerla la Val d’Agri, basta guardare e ascoltare il suono antico che viene da quei cuori, i Cuori Lucani.
Agnese Rubino
A Paterno in prima assoluta la terza stagione della Web Serie “Cuori Lucani”
La terza stagione della web serie Cuori Lucani sarà proiettata in prima assoluta il 15 novembre h. 18,30 presso la nuova Bibliomediateca di Paterno, via Mario Pagano, messa cortesemente a disposizione dall’Amministrazione cittadina. Saranno presenti in sala anche Regista e attori.
La terza stagione di Cuori Lucani è dedicata agli sport: climbing, equitazione, trekking, pesca sportiva, ciclocross. Sport rispettosi dell’ambiente che possono essere praticati nella meravigliosa cornice naturale della Val d’Agri.
Cuori Lucani – terza stagione segue altre produzioni video realizzate nell’ambito del progetto Cuore Basilicata che hanno riscosso consenso tra il pubblico e la critica, visibili su questo sito nella sezione Media: Due Ma Non Due e Cuori Lucani, stagioni 1 e 2.
Due Ma Non Due ha vinto il LOG TO GREEN MOVIE AWARD nell’ambito del FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA ed è entrato nella SELEZIONE UFFICIALE della rassegna VISIONI DAL MONDO – Milano.
Cuori Lucani – prima e seconda stagione, nei Festival internazionali:
Award winner: Roma Short Film Festival, Roma; Tuscany Web Fest, Pisa; Apulia Web Fest, Bari Finalista: Web Series Festival, Hollywood (USA); Vesuvius International Film Fest, Napoli Selezione Ufficiale:Lift-Off Filmmaker Session, London (UK); Golden Short Film Festival, Avezzano; Amsterdam Short Film Festival, Amsterdam (NL) First-Time Filmmaker Session, London (UK)
Appuntamento il 15 Novembre a Paterno!
A pasta ‘co capuliatu
Può capitare che all’improvviso vi arrivino ospiti a sorpresa e, allora, preparare una ricetta in poco tempo diventa un’occasione per stare piacevolmente insieme, magari preparando qualcosa di genuino e al contempo sfizioso.
Una ricetta alla quale si può ricorrere in queste occasioni, facendo sicuramente bella figura, è a pasta ‘co capuliatu.
E’ risaputo che i pomodori secchi rappresentino una miniera di sostanze benefiche per l’organismo come sali minerali, e soprattutto licopene.
E’ per questo che propongo oggi la ricetta tradizionale gelese “a pasta ‘co capuliato”, semplice, veloce e molto…salutare!
Ingredienti per 4 persone:
-400g spaghetti (preferibilmente trafilati al bronzo)
-150g di capuliato
-3 spicchi d’aglio
-prezzemolo tritato q.b.
-peperoncino q.b.
-parmigiano q.b.
-olio extra vergine d’oliva q.b.
-sale q.b.
Procedimento:
Soffriggere in un tegame gli spicchi di aglio con olio extra vergine d’oliva
Non appena gli spicchi d’aglio si saranno leggermente imbionditi, aggiungere il capuliato e farlo cuocere a fiamma moderata per pochi minuti
Sminuzzare il prezzemolo con lame taglienti, in modo da preservarne la fragranza.
Nel frattempo far cuocere gli spaghetti, utilizzando preferibilmente un tipo di pasta “ruvida”, in modo da ottenere una giusta emulsione tra pasta e capuliato.
A cottura quasi ultimata, scolare la pasta, prestando attenzione a conservare un po’ di acqua di cottura e aggiungerla al capuliato dopo aver tolto gli spicchi d’aglio.
Mantecare a fuoco basso per alcuni minuti, aggiungendo se necessario qualche cucchiaio di acqua di cottura.
Aggiungere prezzemolo tritato, peperoncino e parmigiano e servire.
Buon appetito!
L'articolo A pasta ‘co capuliatu proviene da Gela Le radici del Futuro.
Andrea Camilleri e il “giorno dei morti”
“Fino al 1943, nella nottata che passava tra il primo e il due di novembre, ogni casa siciliana dove c’era un picciliddro si popolava di morti a lui familiari. Non fantasmi col linzòlo bianco e con lo scrùscio di catene, si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti, il mezzo sorriso d’occasione stampato sulla faccia, il vestito buono stirato a regola d’arte, non facevano nessuna differenza coi vivi. Noi nicareddri, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini (la grandezza variava a seconda dei soldi che c’erano in famiglia) che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio.
Eccitati, sudatizzi, faticavamo a pigliare sonno: volevamo vederli, i nostri morti, mentre con passo leggero venivano al letto, ci facevano una carezza, si calavano a pigliare il cesto. Dopo un sonno agitato ci svegliavamo all’alba per andare alla cerca. Perché i morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e perciò il cesto non lo rimettevano dove l’avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente, bisognava cercarlo casa casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura quando sopra un armadio o darrè una porta scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano paesaggi. Avevo 8 anni quando nonno Giuseppe, lungamente supplicato nelle mie preghiere, mi portò dall’aldilà il mitico Meccano e per la felicità mi scoppiò qualche linea di febbre.
I dolci erano quelli rituali, detti “dei morti”: marzapane modellato e dipinto da sembrare frutta, “rami di meli” fatti di farina e miele, “mustazzola” di vino cotto e altre delizie come viscotti regina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il “pupo di zucchero” che in genere raffigurava un bersagliere e con la tromba in bocca o una coloratissima ballerina in un passo di danza. A un certo momento della matinata, pettinati e col vestito in ordine, andavamo con la famiglia al camposanto a salutare e a ringraziare i morti. Per noi picciliddri era una festa, sciamavamo lungo i viottoli per incontrarci con gli amici, i compagni di scuola: «Che ti portarono quest’anno i morti?». Domanda che non facemmo a Tatuzzo Prestìa, che aveva la nostra età precisa, quel 2 novembre quando lo vedemmo ritto e composto davanti alla tomba di suo padre, scomparso l’anno prima, mentre reggeva il manubrio di uno sparluccicante triciclo.
Insomma il 2 di novembre ricambiavamo la visita che i morti ci avevano fatto il giorno avanti: non era un rito, ma un’affettuosa consuetudine. Poi, nel 1943, con i soldati americani arrivò macari l’albero di Natale e lentamente, anno appresso anno, i morti persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavano, felici e svegli fino allo spàsimo, i figli o i figli dei figli. Peccato. Avevamo perduto la possibilità di toccare con mano, materialmente, quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva preceduto e “stampato”, come in questi ultimi anni ci hanno spiegato gli scienziati. Mentre oggi quel filo lo si può indovinare solo attraverso un microscopio fantascientifico. E così diventiamo più poveri: Montaigne ha scritto che la meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà, perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servire”.
fonte articolo: da Racconti quotidiani di Andrea Camilleri
L'articolo Andrea Camilleri e il “giorno dei morti” proviene da Gela Le radici del Futuro.